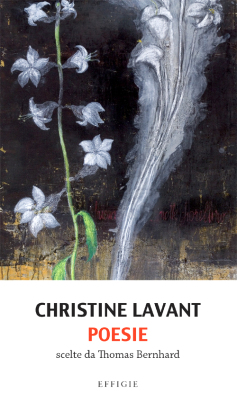La raccolta antologica di Christine Lavant (1915-1973), una delle più importanti poetesse austriache, curata da Anna Ruchat e ora edita da Effigie Edizioni, permette non solo la conoscenza e l’estremità di questa grande autrice ma consente anche di seguirne le linee, approfondire i misteri del suo strenuo combattimento, della sua tenebra densa e dimidiata, e, infine, percorrere le spie lessicali del suo mondo fondante.
Il volume, allora, ripresenta la scelta compiuta nel 1987 da Thomas Bernhard, affinchè fosse resa giustizia ad un’autrice che «fino alla morte non ha trovato né pace né tranquillità e che nella sua esistenza si è flagellata attraverso la sua persona […]; si tratta della testimonianza elementare di un essere umano, che altro non è se non grande letteratura, meno conosciuta di quanto meriterebbe».
Pseudonimo di Christine Habernig-Thonhauser (sceglierà il cognome Lavant, in omaggio al fiume, affluente della Drava, della Carinzia in cui era nata), ultima di nove figli di una famiglia vissuta in povertà estrema, autodidatta, malata di polmonite e scrufolosi sin dall’infanzia, Christine Lavant addensa la confinata percezione dell’essere in una annotata e annodata solitudine, attraversando appieno la peculiare aspettualità carinziana, come «il senso di separatezza, l’educazione cattolica fortemente conservatrice, la Bibbia, le preghiere, le tradizioni e le pratiche di un mondo contadino arcaico, i canti e i detti popolari, la credenza nei sogni, la percezione animistica del mondo creato, quasi ai limiti della stregoneria, la densità metaforica dell’immaginario […]» (Roberto Galaverni).
È nel poderoso annodamento, nella sfibrata cartilagine di vita e felicità, nella connotazione di oscurità e scontro che il suo canto si affina di contrasti e in cui il gesto poetico e la sua peculiare creazione si distinguono, come scrive Anna Maria Curci, «per la tenacia della ricerca e la tensione, solco costante nell’esistenza, tra slancio e scavo. Scrittura che racchiude gli opposti, è quieta e potente, lieve e incisiva, ascetica e concreta, è preghiera umile e ribelle. Lo sguardo si sofferma sull’esistente con visionarietà vertiginosa e sinestesie corpose […]».
Il dire poetico, allora, diventa eterna «semina dell’osservazione» e la parola «s’imprime a fuoco / da sé nella sua corteccia» e da esso la scrittura non giace in un rifugio, manda messaggi ciechi e «inutilmente si rigira / aggredendo il tuo sonno / mentre nel disco della luna / è in salvo la risposta».
Il combattimento è lo spazio dell’anima. In una lettera a Martin Buber, datata 9 marzo 1956, la poetessa scrive:
«Sono poetessa – non sempre, in realtà sempre più di rado, nella vita di tutti i giorni faccio la maglierista. Pare che oggi sia arrivato il momento della spedizione del mio nuovo volume di poesie. […] Ho timore del mio volume di poesie. La maggior parte delle liriche sono frutto di ossessione e di superbia disperata. La prego di permettermi di inviarLe e La prego di leggere almeno alcune di queste poesie e La prego soprattutto di scrivermi (di farmi scrivere?) se Lei mi ritiene un’anima persa, vale a dire morta, defunta, oppure se Lei crede che per tutti – fino all’ultimo istante in cui sono in carne e ossa – ci sia ancora salvezza» (traduzione di Anna Maria Curci).
In questa nevralgica risonanza disperata e lucente, si nasconde l’estraneità al mondo, il suo stretto esilio, la sua vita inadempiuta.
Sostiene Irene Battaglini, docente di psicologia dell’arte:
«L’esperienza di Lavant con il mondo è simile allo sgomento che assale la mente all’idea della creazione dal nulla, poiché nel suo campo emozionale non ci sono picchi e valli, ma è il campo stesso dei significati di un determinato momento a diventare picco o valle entro la quale assestare un colpo alla teoria della fine eterna. Poiché Lavant attribuisce agli oggetti interni lo stesso valore che attribuisce alla sua facoltà di distruggerli o farne l’uso necessario alla sopravvivenza psichica, quasi che il pane o il bicchiere fossero alla stessa stregua del padre e della madre, si può dire che Lavant abbia subito e nello stesso tempo padroneggiato con la maestria del genio poetico la sua potentissima identificazione con quegli stessi oggetti interni, che hanno fatto di lei pane e bicchiere, padre e madre, picco e valle».
Nel solco tracciato da ogni linea, il frattale del respiro rilascia segreti nascosti, là dove si dispiega la Carinzia e dove la sua selvaggia luce interiore celebra la lotta degli occhi e il mondo stravolto, lasciando andare il regno dei cieli:
«[…] Da tempo invecchia nell’ospizio la mia volontà / sul tetto si scioglie l’ultimo fiocco / del freddo sapere e penetra nel legno. / le domande sulla sofferenza del raggio di sole / portano alla luce molte cose dal fondo del pozzo. Lì dentro non guardo mai, guardo nella fossa / del mondo stravolto, dove ci siamo incontrati / e contro gli ossicini del tuo nome / mentre i miei sotto il colpo di sole / si ravvivano. Ognuno arriva a se stesso / e sa quello che è stato ed è, e predice il futuro. / Solo le ossa del cranio schivano ogni cosa / sentono il calore del sole come un puro trivellare / verso il segreto nascosto tra le mie orecchie».
Nel segno cifrato di Rilke, nel pondus animae, nella ricerca elementare e nella invocazione rovesciata emerge una subissale domanda di senso, un cratere di sofferenza che riguarda il cuore stesso di ciò che vive, la sua possibilità di salvezza, il suo canto controluce, la sua fibra umbratile e così «[…] il suo isolamento si configura come una segregazione geografica, non però culturale, anzi è proprio dalla convergenza, a volte dall’esplosivo e doloroso scontro, tra il peso e la ricchezza della tradizione biblica e liturgica, l’animismo contadino, il folclore, e dalla poesia anche d’avanguardia, che scaturisce la potenza oscura della sua poesia» (Anna Ruchat, p. 171).
Roberto Galaverni scrive ancora: «[…] che parli dell’infimo della condizione umana o guardi dal basso alle costellazioni, che nel suo costante riferimento a un “tu” si rivolga a Dio, o volta a volta alla propria anima, al cuore, all’amore, al corpo, alla vita, al creato, o ancora, come spesso accade, discretamente al lettore, la sua intonazione risulta sempre alta, energica, combattiva, senza mezze misure».
La ricostruzione geografica è la fibra della sua ferita, il suo vigore l’intreccio accennato di un affrancamento dal dolore e dal limite, per farsi vertigine sorpresa, per fondersi in una rivelazione frammentata e affilata, come liturgia fossile di pietra e di mele, acciaio e radici:
«Ti ho tuffato nella mia rabbia! / Ora sei d’acciaio sopra la terra / e sotto, mansuete, avanzano le tue radici / tra pietre scricchiolanti. / Non portarmi il grano! Non ti ho reso acciaio / per saziarmi o addormentarmi / a me spetta la metà di quella mela / che matura tra i rami dell’albero del serpente. / Spada o giglio – tu li sei entrambi a metà! / Voglio scagliare in alto la tua affilatezza / ed essere dolce sorella della terra / e indurre in tentazione Dio come lui ha fatto con me. / Ti ha tuffato tre volte nel mio cuore / e ti ha ordinato di rinunciare a lui / ma ti ho immerso nell’acciaio della rabbia; / ora porta a suo figlio la mia metà della mela!».
L’inesorabilità di una domanda a Dio, a contatto con la realtà, si confronta con la dinamica tensione dell’essere, che è intonazione blanda e feroce, allo stesso tempo, di notti senza testa («in una minuscola Babele di polvere / in cui le stelle delle mie pupille assetate / intravedono il flagello di Dio»), contrasto implacabile che si destreggia nella bestemmia furiosa di ruggine e muffa («Dimentica il tuo ciarpame, creatore! / O sarai creatore / di ciò che è cadavere e lo rimane / e si unisce alla terra / ben più volentieri che al cielo»), e divenendo strappo scagliato nella fitta eterna di dita «che non hanno mai disimparato del tutto / la congiura e lo scongiuro», restando annodate nel sudore della paura di sogni caduti, nonostante tutta l’indomita veglia e la gioia del profondo. Una piccola sfera rossa e rabbiosa che finisce appallottolata:
«Mi hai strappato fuori da ogni gioia, / ma io ne soffrirò soltanto, / solo e unicamente, finchè / ne avrò voglia Signore. / In uno stato di ferocissima superbia / e furibonda audacia ti sto davanti. / Solleva la tua mano e fustigami, / vedrai che salterò sempre più in alto / e tu mi avrai davanti agli occhi in eterno, / una piccola sfera rossa e rabbiosa / Ogni punto mi scaglia indietro verso di te / perché tu mi hai strappato via da quell’unico punto / in cui ero cuore, gioiosa e tenera come un uccello, / per poi appallottolarmi / e scagliarmi nel dolore eterno».
L’amore di Christine Lavant verso Dio è uno strappo furioso di mondi racchiusi che avvertono l’angoscia sorgiva e muta dell’istante: solo Lui, infatti, conosce la sua anima e «chi tra la bara di piombo e le rocce / aiuta il fiore a raggiungere la luce».
Tali mondi chiedono la substantia dell’essere e la loro genesi come interrogazione incessante, in cui la sconfessata promessa di felicità, lanciata dalla solitudine, come separato grembo materno, implora perdono all’amore trinitario («Questi giorni non diventeranno vita. / Forse già nel ventre di mia madre il mio destino / s’è coraggiosamente separato da me / e se n’è andato – audace come io non sono mai stata – / sulla stella abbandonata da Dio»).
Oppure nella precisione confinata e sconfinata dell’ultimo tremore rannicchiato, ecco che il grido, nella debolezza invincibile a cui donare le ali, («io voglio masticare la radice della mia debolezza»), si piega alla meraviglia, nel silenzio risoluto del piombo della lingua:
«La mia debolezza si serve di me. / Mi fa piegare verso le pietre del selciato / e fa sorgere nei suoi meravigliati / occhi di rospo il suo doppio. / Nessuno mi riscatta dalla sua presenza. / Fuori mano dondola la moneta della luna / in acque troppo nere, troppo possenti / per le mie dita morte. / Ogni sentimento le ha abbandonate / per rannicchiarsi nelle radici delle mani / timoroso di ciò che potrò intimare / su incarico della speranza. / Tremando il mio cuore suona / il sacro ritmo tripartito, / ma sulla mia lingua c’è il piombo / del silenzio risoluto. / Mai griderò chiedendo aiuto. / Tra le pietre del selciato e gli occhi del rospo / seguo la mia debolezza rabbiosa / nella fortezza del Padre».
La profondità di Christine Lavant è pietrosa e non ha asili. È assolo di pane e pietra sul fondo delle cose, dove rilucono immagini vive e incisioni nel costato, ed è in tale tensione germinativa che riscopre santità e dimora di maledizione, ossia capacità di Assoluto e sospeso ripiegamento, condividendo con i vinti la sua condizione sottomessa e abbacinata, a volte persino seppellita, fino a farsi redenta immagine che irrompe in tutto il suo inarcamento ed entrando nella radice di ciò che vive.
Scavando nella realtà, la sua demarcazione incalza la visione rovesciata della pena, della morte («Mi piacerebbe a volte toglierla dai ranghi / per mettermela vicina nel presentimento» oppure diventa addirittura rifugio consolatorio) e della precisione originaria che sembra scivolare e spegnersi («Ho esaurito le sette richieste / del Padrenostro, / e noto che il senso loro va in fumo / prima che si accendano le luci. / Dio non mi riconoscerà. / Il chiaro di luna scivola via dalla casa, / la stella dal telaio della finestra – / solo quel che penso non si spegne mai / brucia in nome tuo»).
La litania incastonata nella parola rifulge quando si attesta nel fondale dell’umano. Attraverso persino l’invettiva e l’accusa, il senso della colpa di Christine Lavant «sembra essere la sostanza stessa del dolore, e la si può davvero guardare in faccia soltanto quando l’angelo «se ne va, con la tenda della grazia / sulle spalle» (Anna Ruchat, p.172)».
Il territorio della poesia rappresenta l’agone di una devastazione di un incendio di terra promessa. Con la distruzione lancinata e la trafittura devota coabita una sproporzione di scrittura astrale che consente l’indicazione della vita, per non essere braccati e poi, in definitiva, consumati: «Concedimi di essere triste / sotto i tuoi occhi, le stelle. / Forse loro non vedono che sono triste / perché l’orecchio della luna è distratto / e non sente i miei discorsi. / Certo di giorno l’astro solare / non pensa mai che tramonto – / concedimi di perdere me stessa nei cespugli della malinconia».
Una visitazione non solo sacrale ma unita a uno sterminato amore di croce. Non è solo nella bestemmia, nell’invocazione rovesciata oppure nell’accusa che la sua anima manda il suo segnale al mondo, bensì nella fame, nella sete, nella presenza che affama e nelle stelle, rifulge il suo suono possibile e affilato, la sua memoria consacrata, il suo infinito desiderio di consolazione. Il suo ritratto è una stella gracile che cattura la chiarezza delle scorze sfarzose del cielo, mentre il cuore avverte addosso tutta la gravezza del firmamento, senza difese:
«Se mi vuoi visitare / devi prima versare una ciotolina di latte / nella conca del mio cuore / perché lì abita un riccio incollerito / furibondo per la fame. / Se mi vuoi visitare / devi prima mettere un anello di fuoco / intorno al guscio del mio cranio / perché lì uno scorpione velenoso / porta a spasso i suoi piccoli. / Se mi vuoi visitare / devi pronunciare una sentenza sacra / che sciolga la mia lingua di pietra / perché lei nove volte scende all’inferno / per bruciare una parola. / Quando avrai superato tutto questo / sarai il benvenuto, sulla fronte e sulla bocca / e atteso dal più dolce dei cuori / nel segno della croce».
Nella sua poesia esiste un accertamento della propria condizione attraverso un’amara fondazione di territorio dove perdere il filo del tempo, una preghiera che sonda l’adorazione fino a trasformarsi, ma mai un’inimicizia, perché tutto «si muove nei cerchi della malinconia, / solo un suono di campana / loda la fuga delle stagioni / come misura del Creatore / e i primi frutti scivolano / felici nell’erba».
Il segno che si protende è estraneo («Ora però – con gli occhi pieni / pieni di paura – vado cieca / attraverso la luna e la stanza, attraverso il vento / e attraverso cose molto estranee»), come il riconoscimento di una Presenza ebbra, conosce la fuga ed è lontano dal calore umano e dal grido degli stormi, è respiro trattenuto poiché appeso in una oscura scrittura ideografica sacrificale, «e chi verrà dopo di noi, e amerà e sarà rifiutato».
La sua ombra cammina sull’acqua, brillando in modo fugace e febbrile come una luce roca, passeggia da sola, sfilando in ogni cara lontananza e rilasciando stelle annegate e ritirate, per «raspare con la zampa del cuore, / guardare fisso la luna / anche se non risplende»:
«La mia ombra sa camminare sull’acqua, / basta che la luna o il sole siano nella giusta posizione / allora la mia ombra brilla all’apice. / Questo brillare ovviamente è solo vanità, / e non può riscaldare, / non può mai essere reale, / ma qualche volta è merito suo se una semplice pietra / irradia riflessi argentati di fronte alle altre. La mia ombra passeggia da sola, / spesso anche di notte, sfuggendo al sogno più profondo, / allora, come fossi un cavallo, mi aggancia all’albero / del sonno e non mi lascia cibo. / Io chiamo in aiuto il padre, la madre, / anche i fratelli e la morte, / ma loro non mi portano né zucchero né pane, / li sento tutti solo in lontananza. / Mi fanno coraggio attraverso un portone vetrato / e alla fine appare soltanto la mia ombra, / in compagnia di una stella annegata».
Christine Lavant, allora, domanda a Dio qual è la sua porzione di luce, dove sentirsi a casa quando il peso grave della stanchezza insonne fa gridare ogni respiro, quando «la mia bocca è comunque condannata / alla formula magica e a un folle balbettio», Lo prega di procurarle una luce per il sentiero di casa «anche se trafigge accecante il glaucoma del sogno / e tormenta la mia memoria» e la «dimora di un topo / prima che il giorno mi lapidi».
Questa è la radice della sua dimora umana: il bisogno di un rifugio senza fine, l’impazienza dell’anima debole che è costretta a portare il corpo come errore e come colpa, fino a desiderare di essere cieca e «non sentire nulla e mai più accogliere il sole / nel bagliore del crepuscolo», fino a che le labbra possano spalancarsi e seccarsi.
La gioia rinserrata e ricercata per tutta la vita non è un luminoso incanto che raggiunge il tempo in uno spazio, è desiderio di qualcosa che non abbia termine, è il perdono smisurato come misura delle cose e dell’essere, è cuore che si com-muove perchè riconosce una grazia immeritata:
«Vorrei guardare bene negli occhi tutte le offese, / e dire loro che niente al mondo è privo di salvezza / e che nessuna di loro mi ha offeso davvero, / perché ogni volta lo specchio dell’umiltà / cresceva dietro i loro colpi. / Più di tutto devo consolare le prime / quelle che Dio ha gettato sulla mia infanzia / da altre infanzie / nella minuscola aiuola del mio amore. / Ora è arrivato il tempo del perdono. / Sarà perché sto per morire, / o perché tutto ciò che nutriva la mia vita / cade nelle mani della morte. / Forse la gioia è davanti alla mia porta, / una gioia cristallina e dura / che viene dalla forza più profonda della terra? / Prima che arrivi, devo mettere le monetine della pace / sugli occhi di tutte le offese / e aver completato il perdono, / con la commozione nel cuore».
Anche la terra, calpestata e vissuta nei suoi piccoli bulbi, racconta di un amore caldo e duraturo e diviene il fiato silenzioso di radici e sangue, una manciata di spine mendicanti nel male lontano. La poetessa vuole conoscerlo.
È un angelo lacerato «con la tenda della grazia / sulle spalle, e una scintilla delle tue braci ha fuso ora tutto il vetro», ma sa che il Signore, che ha amato, fissato, verso cui ha lanciato strali indispettiti e occhi bassi, è stato benevolo «perché senza di te la campana di vetro l’avrei rotta io».
Vuole dare la caccia al suo cuore con i cani «e farlo sbranare, per risparmiare / un lavoro ributtante alla morte», dire grazie a Dio perché «ora ne so abbastanza».
Lavant C., Poesie, scelte da Thomas Bernhard, a cura di Anna Ruchat, Effigie Edizioni, Milano 2016, pp. 172, Euro 15.