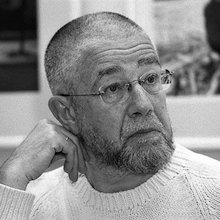La poesia di Sergej Gandlevskij[1] (1952) è una coniugazione di mosaici che rapprende l’evocazione di una festa che origina il mondo, perché la scrittura possa, in qualche modo, far balenare «il luccichio della vita autentica, sia quando l’autore descrive la propria gioventù da assiduo frequentatore di feste in casa, da «perdigiorno» nella patria di Stachanov, sia per il valore esistenziale assegnatole[2]».
Con Festa ed altre poesie, recentemente edito da Passigli, a cura di Elisa Baglioni, dopo il prezioso La ruggine e il giallo, pubblicato qualche anno fa da Gattomerlino, a cura di Claudia Scandura, l’esplorazione del suo verso e lo spazio dell’otium, inteso come rito e come sguardo prospettico, assumono una vertiginosa verticalità, che se da un lato, vede nella impalcatura del quotidiano una sorta di vortice lirico che ingloba ogni dettame lirico-metrico e ogni intreccio musicale e meditativo[3], dall’altro, esprime la piena coniugazione della libertà, della lotta caduca e fragile, della storia del singolo in tutta la sua ampiezza: «Per chi scrive, la conquista di una propria intonazione, di una propria voce, è un avvenimento pari, in quanto a forza, alla liberazione: ora è libero di parlare di quel che ritiene opportuno[4]».
Nato a Mosca da padre ebreo (intellettuale moscovita dell’epoca di Brežnev) e da madre di religione ortodossa, proveniente dalla Siberia, entrambi antisovietici, iniziò a scrivere versi a diciotto anni in un almanacco dattiloscritto della rivista clandestina «Moskovskoe vremja» con A. Cvetkov e B. Kenzeev, che elaborò un’
«ostilità rispetto alla società sovietica che si tradusse in sfiducia verso la missione sociale richiesta all’individuo (e al poeta) per rivendicare un ruolo marginale. Ascetismo urbano, pauperismo sbandato, prodigo e inerme, si trascinarono per i lunghi anni della stagnazione: «la mia neprikajannost´» [incertezza, irrequietezza] sociale rattristava i miei genitori, ha raccontato Gandlevskij».[5]
Si laureò poi in Letteratura russa e dopo aver alternato vari lavori umili, (descritti con dignità ed estremità nella prosa autobiografica Trapanazione del cranio), ha pubblicato i suoi versi soltanto su riviste dell’emigrazione, nel canale del samizdat e, a partire dalla fine degli anni ’80, condividendo l’atmosfera solitaria e sofferta del gruppo Al´manach, si è affermato come uno dei più grandi poeti contemporanei russi nella madrepatria, con diversi volumi fra raccolte di poesie, romanzi e saggi, e la prosa autobiografica Passato e pensieri (2012), vincendo numerosi premi letterari tra cui il premio speciale della Fondazione Josif Brodskij (2013). Ha lavorato alla radio come conduttore di programmi culturali e ha tenuto seminari all’Università Umanistica di Mosca (RGGU), mentre dal 1994 è diventato responsabile del settore critico della prestigiosa rivista russa «La letteratura straniera».
Annelisa Alleva scrive:
«Sergej Gandlevskij, caposcuola dei poeti russi cinquantenni, è il letterato nel senso più completo del termine, perché poeta, autore di racconti e di un romanzo, saggista, critico e autore di una pièce teatrale. Si pone di fronte alla pagina scritta con la coscienza di essere solamente sul gradino più alto di una lunga scala che procede dall’antichità. Quando scrive di sé, in versi, tende sempre a tirare le somme di una vita intera; quando scrive da critico affronta il testo dalle origini, dalla Bibbia, dimostrando una perfetta confidenza con gli eterni interrogativi dell’uomo: il bene e il male, la colpa, la perdita, il risentimento, la paura di morire, la redenzione, la soddisfazione per la propria opera. La poesia di Gandlevskij è complessa da leggere e tradurre, fondata sulla combinazione dell’incombinabile. In modo proustiano […] Gandlevskij fa riaffiorare alla memoria ricordi impercettibili del passato: il grido della strada, di domenica, di un riparatore ambulante di coltelli, una filastrocca oscena di quando era bambino, un particolare dell’arredo della sua casa d’infanzia, un incontro amoroso. Giustappone questi veloci e mobilissimi flash, scorie, frammenti del dormiveglia, provenienti dal sogno o da un sonno premortale, squadernandoli davanti al lettore, così come in alcuni mosaici romani sono realisticamente raffigurati sul pavimento i resti sparsi di un pranzo: noccioli, scorze, ossa».[6]
Il verso che si mostra, che si appropria della biografia dell’anima, che sente la libertà di porgere e sporgere il continuo e sotterraneo occultamento che la società russa post-Rivoluzione d’Ottobre ha iniziato a designare, porta l’autore a esprimere la partecipazione degli occhi chiusi al mondo che si origina di nuovo, nonostante il margine dell’asfalto che trema («Ero libero di non credere alla musica, / ero sacrilego, un bracconiere severo / nella riserva cordofona dell’anima. / Sono libero di starmene al confine / di sfigurare la musica, mia amica fidata-»), la lacerazione strappata («Sotto le mura del Cremlino mandavano / tonnellate, a centinaia, di ferro militare. / Il crepitio non rimpiangeva la quiete, / la terra titillava le piante dei piedi. / Quella notte alla vigilia della parata / cercammo fino all’una un tassì. / Alla vigilia di un rituale estraneo, / nel preludio di un’angoscia privata») e l’orfanezza delle labbra giunte nel silenzio del sapore di cenere, come costellazioni fredde di fragori lontani:
«Conosciamo l’avvicinarsi della burrasca, / un fragore discontinuo da biliardo – / sono secchi e catini che si urtano, / è una tenda bislacca che impazza. / In questa notte d’albergo il sonno / mi ha lasciato a conversare / con me stesso. Coi pedali cigolanti / di una bici, un gobbo è passato / sotto la finestra. Ho tenuto la luce spenta».
Riconosce, in tal modo, la sorgiva tensione dello stupore dicibile e indicibile, la speranza e l’illusione, e il non allineamento della propria grammatica interiore: «Ecco, è inverno. L’alveare bianco è aperto. / L’oscurità è satura di luce calma. / Si leveranno di buon’ora, tra i sospiri / indugeranno e diranno: «Inverno». / Brindiamo col tè ai nostri scritti, / alla vocazione del festaiolo. / Affiorano i contorni di zuccherini. / Viene da sussurrare «Arrivederci». / La sera è lunga, la vita è breve».
Anche i toponimi, le aree fuse, le città dei gulag, i depositi della memoria, sono il segno dell’esistenza ma, allo stesso tempo, la cifra citata del quotidiano che proclama la sua presenza e il suo dettaglio unico e peculiare.
Elisa Baglioni afferma: «Gandlevskij comincia dunque là dove il Secolo d’argento si era interrotto, dal rivendicare il diritto a una biografia, comune e reale, con la sua quotidianità anonima e collettiva, con il suo lessico di strada: nella fattispecie, la storia di un uomo anagraficamente sovietico[7]»:
«Ecco la nostra via, mettiamo, / sia Ordžonikidzeržinskij, / sovietica come ogni provincia, / ma è pur sempre Mosca. / Lontani spuntano agglomerati / industriali senza bellezza, / carcasse, tubi, caseggiati / s’intrufolano tenaci in cielo. / Come vedi niente di che: / farmacia, lampione e una tizia / dall’occhio pesto. Smog ovunque. / Operai in tute scarlatte / già da molti anni lastricano, / rompono l’asfalto e imprecano. / Ecco l’autore del componimento, / aspirando tigli e benzina, / al negozio riporta i vuoti di quattordici bottiglie. / Ecco una signora in là con gli anni, / brava donna, quasi santa, / da un secchiello annaffia i fiori / e dall’alto del balcone / guarda in strada. / In cucina gloglotta il pranzo, / la luce infiamma nelle stanze. / Parenti, mariti e amanti / l’hanno ingannata per bene. / Oggi sarà il mio turno. / Siamo qui cresciuti e diventati / musi lunghi e donne sciocche / ci siamo annoiati e scapricciati – / ecco la nostra via, Signore. / Qui con dischi di Okudžava / e la nostalgia della Vecchia Arbat / da anni sottovoce brontolano / inceneriscono, come drevljani, / le loro speranze idiote. / Coi bimbi giocano alle città: / Ĉita, Suĉan, Kuraganda. / Invecchiano i volti e i vestiti. / Perdono tempo i pescatori / sull’acqua morta del fiume Jauza. / Eccola qui, la Yoknapatawpha / gioca alla schedina l’ultima / scommessa (che a un passo da noi / è il diluvio) e si chiede chi / sia il colpevole, sarà mai Puškin? / Prendevamo dieci in questa scuola / ai corsi di vergogna e terrore. / La vita finirà e taceranno / per sempre insulti e maldicenze / all’ombra del vecchio cortile. / Ma quel dannato buco ci sapeva / imparentati dall’orfanezza: questo eravamo. / Così i bambini nell’antichità / riconoscevano dalle voglie».
Fondendo l’archeologia del detrito depositato, egli spinge l’arsi poetica verso la restituzione di una forza vitale, di una voglia di casa che imbratta il passato. È erba tremula nei lunghi viali di tigli, come una vita vissuta a perdifiato: «Accade certe sere che l’erba tremuli / sotto il temporale e rantoli il doccione. / È facile allora vagare e tormentarsi per i lunghi / viali di tigli conventuali. / La mia vita è sorpresa dal soffoco / dei tigli moscoviti, e viene voglia di casa, / dove imbrattavi la carta di china nera / e cominciava il mio passato».
La lunga linea di Gandlevskij diviene l’esito scrutato di una vertigine temporale che lega l’impermanenza al mistero. Scrutare le pieghe dell’essere, i particolari, le distanze, i tremori, i suoni concitati che scrivono, per rimuovere l’accenno del tempo dei fogli di quaderno, illuminati male della propria vita barbara e del proprio fiato sospeso sottotraccia e, infine, per riportare all’emersione dell’ordinario:
«Nella vita vegetativa di un poeta / arriva un periodo nefasto quando / allontana la luce del cielo / e teme il giudizio dell’uomo. / E dal fondo di un pozzo cittadino / spargendo miglio ai colombi, / pronuncia il terribile giuramento / di rivalersi all’occorrenza, ma / grazie a Dio, sulla veranda della dacia, / dove il gelsomino sfiora la mano, / dal violino convulso di Vivaldi / imparavamo a volare–ecco / il vuoto sale in alto, / dall’alto del vuoto cade a terra / l’anima e si raggela, / ma i fiori carezzano il gomito… / niente sappiamo come si deve, / siamo codardi, beviamo la vodka, / spezziamo i fiammiferi per l’ansia / e rompiamo i piatti per debolezza / ci impegniamo senza adulare / a dire la pura verità, nient’altro che. / Ma le poesie non servono a far vendetta, / sono la fonte di un onore argentato».
Ed ecco che la festa, allora, diventa l’attimo denso di una partecipazione non stretta in un pugno, ma la viva promessa di un’attesa, di uno sguardo che congiunge e mischia l’ebbrezza alla disillusione, il ricordo alla bellezza, la presenza alle cose mancanti, che vivono nell’agguato del linguaggio:
«È il giorno della festa. Le rose nella vasca. / Il fumo, il rumore, non c’è dove sedersi. / È chiassosa, preziosa, / a lungo attesa. Sei in punto. / La sera. L’estate. Gli ospiti presenti. / La gioventù dorata / in corridoio fuma e beve – / saluti, risate, baccano. / Sembra ieri / quando lasciavo i banchi di scuola / per calarmi nel chiasso festaiolo / che non chiudeva occhio. / Suonava a lungo un vinile. / Un allegrone animava la festa. Setun´, Tušino, Stromynka – / è stato bello, perfino troppo. / Qui, per grazia di Dio, / ho trascorso mezza vita. / La donna è seduta / un poco a destra. L’ho amata. / Acqua passata. Ai pronostici / mi affidavo in altri tempi. / Gli uccelli, le farfalle e le libellule / sono simili a questa musica. / Se non fossimo sbronzi persi / di vodka, rumore e tabacco / potremmo uscire sul balcone / ad ascoltarli – musica ed uccelli. / Notte mia! Il lillà ha illuminato / la cabina telefonica / di una luce amarena. Ne parla / il fruscio dei vecchi tigli. / Hanno preso di tabacco le rose / arrivate dalla Georgia. / A mezzogiorno davano rovesci / i rovesci sono iniziati a mezzanotte. / L’acquazzone batte a più non posso, / scroscia ancora a dirotto. / Ha lastricato il selciato / di specchi senza cornici. / E albeggia. L’aria pungente / lambisce la tenda. Se n’è andata / la donna. La padrona di casa / sparecchia la tavola. / Dorme il santarello, dorme il mattacchione – / Dormire! E la mattina ancora / un’altra festa. Tutto al mondo è festa – / azzurra, rossa e nera».
Il cuore del poeta è la condensazione di ogni stagione in un unico dettaglio che si dilata nella lingua racchiusa e poi accresciuta nella lontananza, dove persiste sottotraccia il gemito della parola splendente, ma spesso deteriorata, straniata, usurata, e in definitiva, inconsolabile: «Al Falstaff della gioventù ho detto addio / e ho preso il tram. / A poco a poco sono evoluto, / dal perdigiorno che ero mi ritrovo un burbero. / E tuttavia aprile / con le sue gocce analcoliche / mi dà alla testa come il luppolo. / Non è tempo di montare casette per gli storni / con lodevole impegno? / Non è tempo che io colga nel segno? / In breve, sono inconsolabile».
L’enumerazione interna è l’istinto della voce che ordina l’oralità di ogni evento che accade. La memoria, e poi la memorizzazione, sono il soggiorno di un’evocazione infinita che ridesta i residui e dà luogo all’essere:
«Tutto in una volta – gli oggetti in corridoio / la partenza e i preparativi nella fretta / sei rose appassite e il crematorio / il presentimento nelle poesie / i preparativi ancora un viaggio lontano / se stesso allo specchio e lì sotto / un torsolo di mela secco / così è la solitudine in persona / o per una breve stagione / dieci ormai trascorsi / lui e lei come fratello e sorella / si dicono qualcosa l’azzurro / a quadretti della carta da parati / e il cristallo che si conviene / nelle feste familiari un particolare / qualsiasi i dettagli uno a uno / inclusa l’illuminazione delle stanze / e i mobili, il comodino il comò / gli sci dietro al comò / li ricorderà / al risveglio per addormentarsi di nuovo».
Annelisa Alleva scrive ancora:
«La poesia di Gandlevskij è interna, nel senso che è piena di nomi di quartieri moscoviti, soprattutto periferici e operai, di nomi di attori (Pljatt), indecifrabili sigle di epoca sovietica […], sigarette da poco, termini gergali, nomi di filosofi, filologi (Barchudarov, Krjučkov), amici […] che possono essere riferimenti, spie solo per quelli che in Russia sono nati e vissuti. Una Russia uterina, chiusa fra le pareti di un interno domestico da cui si ha molta voglia di osservare il mondo, ma poca voglia di uscire. E anche profondamente letteraria, quindi echeggiante di rimandi».[8]
L’amore e il sillabario di donna, la vita vissuta, i colori della realtà sono l’origine di uno stupore assetato e silente, nato nel dolore intenso e nel vuoto di un sogno annotato, di un istante in silenzio e di un’abitazione, come segnali di vita.
Esiste, persino, il paradossale richiamo del tempo oltre la morte vagabonda, come se l’anima da osservare potesse protrarsi, accogliendo il perduto e il ramingo, ciò che è estraneo e ciò che è ebbro. Così come la vecchiaia è il tempo delle tende scostate e dello sguardo all’interruttore nero senza timidezze lungo il cortile.
Il suo sentimentalismo critico, se, da un lato, tende a seguire le linee puskiniane (come il componimento Ho trent’anni e tu ne hai diciassette, che unisce il ricordo del Don Giovanni alla sfrontatezza ottocentesca), dall’altro, esplora una figuratività dolente e dimessa, una enumerazione che è andito di sguardo («La mia è generazione di guardiani»), distacco e vita perduta, distanza e risveglio («Rimane ancora che ogni uomo / ricordi quel che non è, / diretto, ad esempio, in farmacia, / avvolto in un silenzio che pulsa. / In piedi sotto il colubro officinale, / osserva l’esultanza del male / senza cattiveria, non perché sia buono, / ma per la vita già trascorsa»):
«Come un angelo, maledetto per il suo riserbo, / come il meriggio a settembre, né afoso né freddo, / così io divento, e qui quasi sto, / non gioisco delle gioie non lamento i dispiaceri. / Tremola ancora la linea del tramonto, / inesprimibile, come quando ero vivo, / e le voci di due pastorelli turgeneviani: / – ma non la scuola – la suola, coglione! / E poi – ah mio Signore – l’ultimo riflesso del giorno / distende la lama dall’amaca alla stalla; / l’ha mancata di poco e s’è fatta subito sera. / Morirò – mi amerete, come non lo sapessi… / E alzarsi, drizzarsi, sussultare, per che cosa? / Dire andate via, portate rispetto, siate felici? / Ma la casa è piena di ospiti, appesi i paltò. / Ospiti a bizzeffe, taciturni come in ascensore. / C’è la NN senza reggiseno e con lei uno sbarbatello. / Uno sveglio di Salisburgo, un tipo di Rostov. / Un uccellino, uno scarabeo, dell’erbetta, infine, / Quisquiglie, pinzillacchere e nient’altro».
Lo svelamento dell’universo per una felicità piena ha l’odore dei colori a olio, il tintinnio del ninnolo cinese, il ridere in pieno giorno. Il poeta costella la pagina di un riempimento in cui si relizzano, come afferma Paolo Febbraro nella nota di lettura a La mia vecchia giovinezza, la vecchiezza mia giovane:
«l’autoironia per la cechoviana e luminosa banalità della propria esistenza; la finzione di prendere sul serio l’oppressiva burocrazia prima zarista, poi sovietica e poi semplicemente eterna; l’addio alla donna amata, la promessa di ricordarsi in un aldilà visto come «collettivizzazione del non essere», un frustrante ritorno al comunismo dei senza nome. Il destino individuale, la memoria privatissima e l’oro dell’intimità erotica vorrebbero conservarsi, nascosti e irripetibili, ma vanno dichiarati «per esigenze di servizio» alla dogana dell’ultimo espatrio e molto probabilmente gli inflessibili ufficiali di frontiera ci perquisiranno a fondo, sbiancheranno i dossier più gelosamente ricopiati. Forse «è il caso di salutarci in anticipo», dice il poeta. Coltissima e domestica, popolosa di figure quotidiane e raffinata, la poesia di Gandlevskij ha diversi di questi momenti di grazia, in cui le strettoie della Storia si rivelano il migliore punto di osservazione per lo sconfinato paesaggio che scorre fermissimo di lato.[9]
Il fruscio della parola distillata è il tempo incluso della moria prima di ogni ultimo transito e Gandlevskij, così scrive:
«La mia vecchia giovinezza, la vecchiezza mia giovane / è qui descritta per uso di ufficio. / Niente che manchi! E niente che sia speciale. / Pure quello di cui si dispone, a niente si riduce. / Non vedessero gli occhi miei come il mio tempo / a fatica avanza verso un collettivo non essere. / Saremo bell’e rovinati, espropriati: punto. / Non è meglio salutarci, sciocchina, stellina, carolina? / E nel lasciarti ai compagni del konsomol o ad altri stronzi / ti dirò infine: ricordati di me. / Per la tua giornata nera metti bene al sicuro / le nostre smancerie riflesse / sullo specchio nudo dell’armadio che la neve ha illuminato. / Se sapessi a memoria i sospiri della tua lussuria / se li avessi con me, quando mi chiameranno armi e bagagli, / a patto che la memoria sia equiparata agli effetti personali».
Gandlevskij S., Festa ed altre poesie, a cura di Elisa Baglioni, Passigli, Bagno a Ripoli (Fi) 2017, pp. 142, Euro 17,50.
[1] Gandlevskij S., Festa ed altre poesie, a cura di Elisa Baglioni, Passigli, Bagno a Ripoli (Fi) 2017; La ruggine e il giallo. Poesie 1980-2011, cura e traduzione di Claudia Scandura, GattoMerlino, Roma 2014.
[2] Baglioni E., Il giorno libero della poesia, in Gandlevskij S., cit., pp. 10-11.
[3] Garzonio S., La musica del quotidiano, in “Il Manifesto”, 4 dicembre 2014.
[4] Gandlevskij S., Ŝum slovarja (“Il fruscio del dizionario”), in Najti ochotnika (“Trovare il cacciatore”), SPb, Puŝkinskij Fond 002, p.101.
[5] Baglioni E., Il giorno libero della poesia, in Gandlevskij S., cit., pp. 6-7.
[6] Aa.V.v., Poeti russi oggi, a cura di Annelisa Alleva, Scheiwiller, Milano 2008, pp.67-68.
[7] Baglioni E., cit., p.12.
[8] Alleva A., cit., p. 69.
[9] Febbraro P., Nota di lettura a Sergej Gandlevskij, in “Poesia d’oggi”, “Il Sole 24ore”, 18 gennaio 2015.