È stata pubblicata finalmente, in Italia, per le edizioni Effigie, la prima antologia della poesia di Helga M. Novak, pseudonimo di Maria Karlsdottir (1935-2013), Finchè arrivano lettere d’amore[1], curata e tradotta da Paola Quadrelli, che raccoglie i testi scritti tra il 1956 e il 2004.
Nata a Berlino-Köpenick nel 1935, abbandonata dalla madre (il padre, che non conobbe, si tolse la vita pochi anni dopo) e cresciuta in una famiglia adottiva a Erkner, a quindici anni, entrò in collegio per la formazione dei quadri del Partito socialista unitario, rappresentando
«il comprensibile tentativo intrapreso da un’adolescente sola, inquieta e infelice di sfuggire a un ambiente familiare anaffettivo, meschino e patentemente fascista, e di cercare un surrogato della famiglia nella comunità politica. Il constatato divario tra la teoria e la prassi, nonché l’autoritarismo dell’educazione impartita in collegio, contrassegnata da dogmatismo politico, dalla continua frustrazione di ogni curiosità intellettuale e da un clima di diffidenza e delazione (gli anni del collegio sono narrati in Vogel federlos) conducono presto la Novak, una ragazza dall’intelligenza critica e vivace a un sentimento di forte disillusione».[2]
Entrata in conflitto con le autorità della Ddr, già iniziato nel 1957, quando fu costretta a interrompere gli studi universitari di Giornalismo e Filosofia a Lipsia, fuggì in Islanda, riuscì a riottenere un posto presso una fabbrica a Berlino Est.
Il suo periplo sradicato non conosce pace: Islanda, poi ancora Germania federale (presso il prestigioso Istituto di letteratura “Johannes r. Becher” di Lipsia e successivamente a Francoforte sul Meno e Berlino Ovest). Dopo essere stata privata della cittadinanza per «sentimenti antisocialisti» nel 1966, conobbe l’espatrio e l’esistenza raminga: Jugoslavia, Spagna, Portogallo, Usa, infine, la Polonia sabbiosa nel 1987, poi, con infinite difficoltà la Germania, con il ritorno ad Erkner, dove divenne cittadina onoraria.
L’itinerario di Helga M. Novak è, quindi, una stretta di rivelazioni che sedimentano argilla di geografie e hanno sete di acque vive. Nella trama inabissata delle sue metafore, brucianti e bruciate, chiare nella loro sofferta intensità, vibra un’epica vivente di «ruvida tenerezza», come afferma Paola Quadrelli nell’introduzione, citando la vivida evocazione di Wolf Biermann, nel 1979, che definì la poetessa tedesca come «la maggiore poetessa della Ddr».
Roberto Galaverni scrive:
«Più che costruire ponti o relazioni, i suoi versi sembrano voler tagliare, incidere, circoscrivere. A volte, specie quando si tratta delle molto dolorose vicissitudini personali, queste poesie tentano anche di ricucire, ma è vero che si avverte comunque da parte della Novak il timore di una riconciliazione meramente estetica, e allora la sua decisione sempre rinnovata di non fingersi nulla, di non fare della scrittura poetica lo specchio delle proprie illusioni. In realtà, la sua poesia non testimonia alcun male di vivere costitutivo, nessuna volontà di negazione metafisica. Al contrario, si tratta sempre di vicende determinate e di rinnovare, se possibile, il proprio credito verso l’esistenza, qui e ora».[3]
Partendo dal debito brechtiano, racchiuso nel sarcasmo e nella dolenza errante, la Novak costruisce i suoi assi attraverso i fuochi foschi e brillanti, i cenni e le pennellate fluide del suo gorgo privato, il dialogo mai trattenuto del tempo elementare, cogliendo la infinita vastità del vivente, fissandola nel suo evento, attraverso un esterno interiore, che è epica profonda, taglio, illuminazione e buio che si compendia:
«carta carbonizzata innevava la strada / lanterne sghembe ondeggiavano ebbre / le finestre a inferriate della scuola di mattoni / tenevano al sicuro in cantina quaranta bambini / le mura della città andavano in cenere / di fronte alla scuola c’era un albero di gelso / e un bambino nei bagliori dell’incendio / si ingozzava la bocca di dolci more / la scuola in mattoni e bruciata per intero / le inferriate tennero bene / i quaranta presero fuoco come libri urlanti / da ultime s’infiammarono le braccia protese / il bambino ha smesso di crescere / – uno scemo qualsiasi – e / mentre sulla cenere crescono le cipolle / lui continua sotto l’albero di gelso / a ingozzarsi la bocca di dolci more.» (sotto il gelso).
Lo spasimo ribelle della fedeltà alle cose e all’essere è un territorio di sguardo che diventa l’heiniano passaporto lucido e l’holderliniano inchiostro affranto di una relazione in atto con il mistero che indica le proprie patrie, i corpi violati e martoriati come anelli distrutti, i lamenti di un tempo indicibile e vissuto, il segno individuale e commosso di una appartenenza e di una conoscenza, che è cifra, linea e pagina notturna, come schianto di salici:
«sono fedele agli alberi come un cane / il salice squassato davanti a casa / su cui anni fa un fulmine è caduto / si innalza di notte nei miei sogni / e da lontano si odono i nostri lamenti / sui nostri due tronchi / sui nostri due corpi / sulle nostre due patrie / io non lo so perché / i miei nervi palpitino ancora / di questo antico incompreso incompiuto / nauseabondo e lungo amore / ovunque il pane viene messo in forno / e ovunque lo si vende a caro prezzo / io fuggo la mia terra e il salice / e faccio ritorno indietro / sono fedele agli alberi come un cane» (fedeltà di cane)
Ma il tempo della poetessa è decentrato e sradicato, deporta il suo evento compatto nei particolari minimi che affastellano tempi universali sulla strada catramata.
La profondità della memoria sembra non conoscere alcuna compensazione, percepisce la sua furia, il momento lasciato, la violenza che si impossessa del corpo tracimandolo, facendo vittime, scompensando gli scarti minimi.
È strappo ricondotto dalla ferita ricucita, poliedro di un battito che riporta i punti lacerati ad aprirsi in uno scavo di lacrime gioiose e disperse, come accade in Lacrime di generale, con
«il ritratto inconsueto e straniante di un potente della Storia in visita privata sui luoghi delle sue vittorie militari – si tratta del generale Paul Emil von Lettow-Vorbeck, uno dei responsabili dello sterminio dell’etnia Herrero nell’Africa occidentale tedesca – e la sarcastica pointe finale richiamano appunto quelle poesie brechtiane in cui la grande Storia e indagata attraverso il prisma di una vicenda personale che si fa apologo esemplare e parabola didattica».[4]
La poetessa, infatti, scrive: «le buche nel deserto profonde venti metri in cui le / donne Herrero, scacciate via, scavarono invano in cerca di acqua ai / cui bordi sono morte prosciugate a centinaia assieme ai loro figli / non le ha trovate / erano già disperse / per questo, lì, non ha potuto piangere».
Il velo del suo tempo è un controbattito stellare che divora la realtà, la spaccatura di una rifinitura aperta, per vivere il fondo della parola, la sua anima infinita che risveglia, e tenta di rammendare, la fluidità franta dell’esistere, come ultimo bagliore sul crepuscolo.
La parola, dunque, nasce in quello strappo furioso e cieco. Sente addosso l’impeto di un gesto violento, perché la Storia che si dà è l’offerta abissale dell’umano, delle pietre trasportate e del volto offeso:
«la sua vocazione nella vecchia Siberia / all’epoca degli esiliati prima del diciassette / era lo staffile per gli infelici / e il cappio per i recalcitranti / ma questi ultimi erano coperti / sul tragitto verso la forca / da un sacco infilato sulla testa / il profumo di un albero / il grido di un uccello / il fremito di un essere umano / nulla / l’uomo con knut e sacco / sistemava la corda attorno al cieco / inebetito e tirava / lo lasciava penzoloni e poi lo gettava/ via come il lavoro gli consentiva / del sacco aveva bisogno / contadine hanno deposto / l’uomo forse delle ubriacone / miserabili per lo più / i cui figli – nati morti – / sono diventati strumento / per divenire uomo bisogna / guadagnarsi il pane in un modo o nell’altro / l’uomo con knut e sacco / vive ancora noi ci conosciamo / forse mi appenderà domani» (L’uomo con knut e sacco).
Il tragitto umano, però, è una trafittura di esilio ingrato, in cui è possibile, nelle traiettorie dello sguardo, aprire la fenditura dell’essere alla luce, nei quartieri scavati o nelle fessure della luce chiaroscurale. La patria è il campo aperto di un rifiuto, di un abbandono, e in definitiva, di un amore recluso:
«niente valle glaciale / persino le pietre sono emigrate / in un campo di mais del Meclemburgo / tra i pini della Marca ancora / mi imbattevo in questa o in quella e spesso / pensavo a quanto fossero lisce / adesso me ne sto in esilio smarrita / su un mucchio di ghiaccio su un mucchio di lignite / su un mucchio di legna su un mucchio di vetro / su un mucchio di sacchi sfondati / oppure cammino sulla battigia e contemplo / le mie grasse orme piene di acqua marina / non voglio lasciarmi levigare / piuttosto affogo qui nella grappa / le pietre sono andate via in Germania / ahi, valle glaciale» (esilio ingrato).
È il suo atto di fede e d’amore che cresce sui lati spogli e nei grumi rappresi della speranza. Un’appartenenza, che pur nella disperazione spezzata dei recinti confusi e delle lingue lontane, nel pane salato, nello scherno e nello sconforto, costruisce il suo sipario splendente, il suo volto non piegato, il suo caldo grembo e il suo nome, gridato e slacciato, il suo essere che non cerca altro che un letto e un ritorno, stesa sotto baci migliori e vaste foreste:
«sono una tedesca dell’Est; ti vien dietro / come il fumo negli stoppini appena spenti / sono tedesca dell’est, ti cresce / come un fungo tra le dita dei piedi / conto i centesimi del mio marco / il soldato che non ho arruolato / ne mangia sempre la sua percentuale / sono tedesca e non solo / per la lingua / sono tedesca dell’est finché / i pali non marciscono / finché diffidenze e spie / insaporiscono le salse fatte in casa / me ne sto seduta al lato spoglio del tavolo / sono tedesca dell’est e trascino / dietro di me un grumo di speranza» (atto di fede).
Nella borsa piena, le chiavi di casa aprono porte inchiodate e buchi rattoppati, il soffitto sembra piegarsi e non si è mai a casa, tanto che nella propria piaga si desidererebbe persino non essere:
«di shock e traumi sono fatta / ahi quanto si deve capire e sopportare / e come vado scavando nelle altre persone / per vedere se abbiano vita più facile della mia / alzatami dalle ortiche cado / nel formicaio più vicino / vorrei essere risparmiata / dalle mie esperienze della mia vita / dai miei antenati dalle mie sconfitte ed estasi / per una volta non essere invadente diffidente / ritrosa maligna avida bonaria asociale / per una volta non essere» (per una volta non essere).
Il dolore acuminato e il lutto si condensano nella sua festa in nero, nei gradini di legno tra le soglie, nelle malinconie screziate, come campana, privata del batacchio (ballata della campana esiliata) nella riversa Uglič:
«sera / è una stanza piena di fumo / fumo grigio freddo pesante / squarciato da luce elettrica / sera / è una finestra senza tende / la finestra uno specchio / con la notte che recita la parte del mercurio / è uno specchio / con la stanza il fumo / la luce elettrica / in una cornice dipinta di bianco / sera / è una parola / di ogni giorno la sera intona un concerto di danza / una danza di parole / attorno al vitello morto l’indomani / sera / sono fogli di carta che svolazzano / finché il fusibile / non viene svitato / sera / è una festa in nero» (sera).
L’ordito di Helga M. Novak è un nero sciabordìo originale di freddo e fumo, ma non si infila nel lamento di una condizione, bensì sente la gravezza di uno spasimo lontano che volge verso un riparo, una patria solerte, un tempo di casa, oltre le punizioni (la donna col righello), i grumi assediati (fortilizio celtico presso Römhild), le brutalità del Potere, come bisogno di chiarore assetato ed escluso:
«a casa mia fioriscono i ciliegi / la terra fresca dissodata sputa larve / e lombrichi e odora forte / a casa mia i muri di casa / sono ogni giorno più caldi / nei boschi dove l’erba dell’anno passato / diventa così asciutta / che ci si può stendere sopra / le foglie di quercia cadono per ultime ma ora infine cadono / solo il muschio sciaborda ancora sotto i piedi / e conserva al suolo un vino asprigno / a casa mia il cuculo grida / cinquanta volte / vivremo ancora cinquant’anni no di più no per sempre / a casa mia / che non mi venga da ridere / casa tua fammi vedere / a casa mia fioriscono i ciliegi / e il lillà / e nei castagni si librano gli amenti bianchi e rossi / del bruciante e buono amore» (a casa mia).
L’innata consistenza libera è un’urgenza, una tensione che palesa il lato oscuro dell’esistere, delle relazioni, dell’evento. Ciò che accade è il registro di una vastità che non si concentra nel silenzio annegato o nella non vita. In questa lotta furibonda e dolce, la metafora caparbia della poetessa, oltre l’abbandono ebbro, la rabbia, la fragilità femminile, l’oppressione, la deportazione e il gelo delle cose, vibra nel rialzo dopo la caduta. È dramma di ali paralizzate, poesia, velatura insonne di una dichiarazione d’amore, covata nel silenzio del volo:
«sembra proprio che io abbia / disimparato a volare / non mi innalzo più e non cado / con le ali paralizzate / sto qui seduta a covare / dichiarazioni d’amore / eppure ci sono tanti uccelli / che non si staccano mai da terra / e tuttavia saltano e si pavoneggiano / con piume arcuate / nell’erba svolazzante / io per oggi sono una folaga / e ti cerco nel canneto / dove sei rimasto / sicuramente impigliato / a uno dei tuoi tanti peli neri / non credere che io ti lasci andare» (non m’innalzo più e non cado).
La poesia che vive sull’abisso, fissato come una lunga lettera buia (lettera a Medea), ha ferocia tenera («al soffitto della mia stanza sono attaccate / assieme due falene innamorate / grandi come il palmo di una mano dispiegano / quattro ventagli neri e grigi / con puntini gialli cadono giù / nere dal soffitto alla coperta / cadono senza separarsi»), e guardando con stupefacente tremore, partecipa al movimento estremo del reale, curvato come pietra che scende nell’acqua o come sogni e legami: la propria origine è un lungo campo che si fa evento, respiro, biglietto, supplica vivente (supplica per Sarah).
Il legame tra esistenza e lingua conduce la lontananza a essere parola che respira, si incide, ed è pioggia che fende. Le lettere d’amore di Helga M. Novak sono un recupero di detriti non perduti e impossibili, non brancolano, non inciampano, ma chiedono solo l’annuncio di un ricongiungimento e tentano di ricucire lo strappo perenne della morte alla finestra: «finché arrivano lettere d’amore / non tutto è perduto / finché mi raggiungono abbracci / e baci seppure per lettera / non tutto è perduto / finché nei pensieri / vi chiedete dove io sia / non tutto è perduto» (finchè arrivano lettere d’amore).
Oppure affermano il solco vuoto dell’orfanità, la vulnerabile friabilità, il desolato stigma interiore. La casa incendiata da un amore sterminato, il velo di acqua sugli occhi, la fabbrica di sogni sui binari, la patria di nuvole verso le barriere di luce e la punteggiatura di dolore racchiudono il suo stemma interiore, sospeso nell’aria:
nessuna madre mi ha mai nutrito / né mi ha cambiato una camiciola / colei che mi mise al mondo sentì / solo la propria sofferenza / io per lei non fui mai / libera ero all’età di tre giorni / fu un bene che mi liberarono cosi presto / poteva prendermi chiunque mi vedeva / sorridente priva di obblighi con chiunque / son dunque libera e ingrata / dal mio terzo giorno di vita / adesso che nessuno più mi vuole / a cinquant’anni il sorriso e un altro / e nessun amore mi viene in soccorso / patria e contrada perdute da tempo / priva di padre da sempre / la testa si fece saltare di buonora / con un sol colpo cosi son libera e schietta (nessuna madre mi nutrì).
La bellezza furiosa della poetessa avverte il senso dell’estraneità e la distanza dal compimento, dall’esser-ci, subisce il rischio della cancellazione della parola che è la forma del suo strato più profondo, dove il fiato non si estingue, dove lo spaesamento è scomparsa, pacificazione ultima e approdo precario («e di nuovo scompaio nelle dune / qui non passa l’aratro e sprofondo / in basso e più in giù nel rado campo di urne / liquidate sono le mie ferite / dimenticati vino e pane le poche canzoni / sbiadite come le labbra sul bordo del bicchiere»), scomponendo la dismisura dell’anima in un disegno che si rigenera:
«dove fragili urne non smettono / di crescere lì è il mio campo / dove vagano verso l’alto e verso il basso / i vasi di terracotta pieni di cenere / io sono in costante cammino / verso il mio campo arato di cocci / la mia sabbiosa area di smistamento / in mano di nuovo un’anfora / ruvida sigillata con argilla / nessuno mi vede sotterrare / la tua cenere seppellire / i poveri resti nell’oscurità porosa / con terra rossa cospargo il luogo / per corredo un bicchiere da te e un coltello / gli ordinari cucchiai di osso / l’ambra che galleggia nell’alcol / e in aggiunta del mio volto la maschera / davvero tutti questi condotti a sepoltura / simulano un triste sacrificio / inceneriti seppelliti calpestati / ma la nostra Madre terra non riesce a / gettare via nulla conserva ogni / carabattola rovista ed estrae / cenere in vasi incrinati».
Novak H. M., Finchè arrivano lettere d’amore. Poesie 1956-2004, Effigie Edizioni, Milano 2017, pp. 229, Euro 17.
Novak H. M., Finchè arrivano lettere d’amore. Poesie 1956-2004, Effigie Edizioni, Milano 2017.
Galaverni R., Helga tra le dune liquida le sue ferite, in “Corriere della Sera – La Lettura”, 29 ottobre 2017.
Quadrelli P., Helga Maria Novak. Canti di una senza patria, in «Poesia», giugno 2016.
[1]Novak H. M., Finchè arrivano lettere d’amore. Poesie 1956-2004, Effigie Edizioni, Milano 2017.
[2]Quadrelli P., Helga Maria Novak. Canti di una senza patria, in «Poesia», giugno 2016, ora in Id., La «ruvida tenerezza di Helga M. Novak», in Novak H.M., Finchè arrivano lettere d’amore. Poesie 1956-2004, cit., pp.6-7.
[3]Galaverni R., Helga tra le dune liquida le sue ferite, in “Corriere della Sera – La Lettura”, 29 ottobre 2017.
[4] Quadrelli P., cit., pp.10-11.



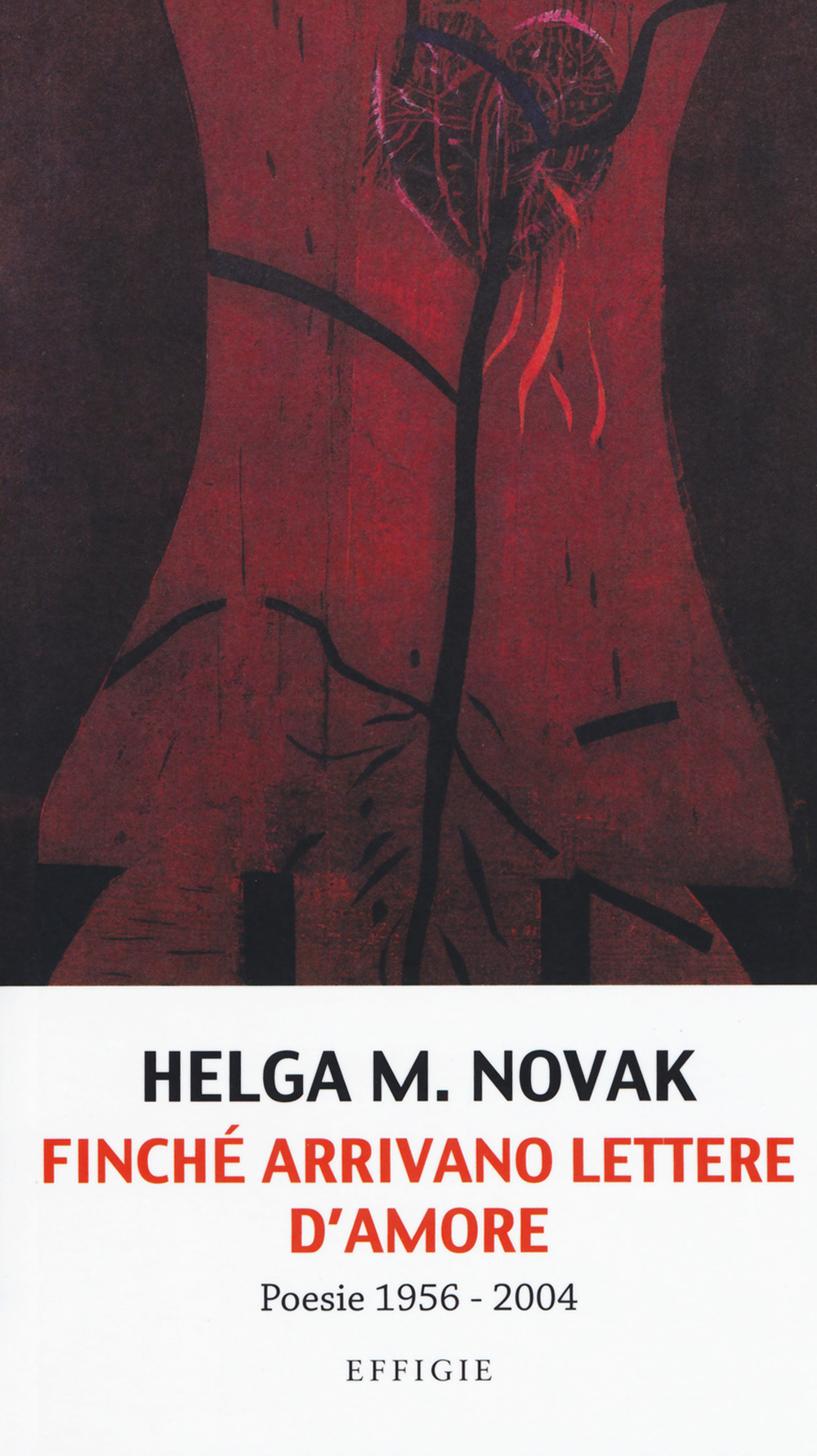
Pingback: finché arrivano lettere d’amore – Helga Maria Novak « Poesia in Rete