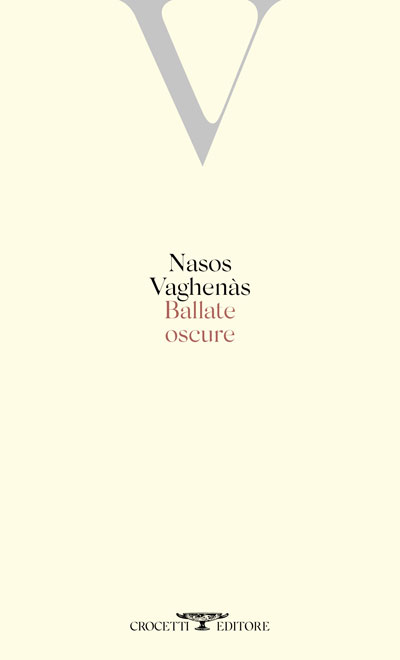La lunga tradizione europea che risale fino a Borges e Kavafis, la raffinata linea dell’appartenenza, il fuoco dello zen, la potenza umbratile dell’eros segnano l’orizzonte di Nasos Vaghenàs (1945), poeta della generazione del ’70, che tenta di riconsacrare la parola poetica, rivitalizzandone l’uso, il ritmo, l’importanza del verso libero, restituendo la grazia naturale di una autorialità non scambiabile.
L’ironia («Prima dell’Ade, c’è vita? Se c’è / non è quella che adesso ci tormenta. / ma se fra i ciechi il monocolo è re, / certo qualche conforto si argomenta / da una breccia del tempo, in cui convolano / i raggi di altri soli /che non provocano / ustioni, un inconsulto odor di viole, / suoni inauditi giunti da un altrove»), gli strumenti umani, l’intimismo intenso riconducono la sorpresa della ballata, come movimento epico-lirico.
In queste Ballate oscure[1], pubblicate nel 2001e riproposte da Crocetti, a cura di Filippomaria Pontani,
«emerge una finissima sensibilità per temi come l’amore (in particolare le pieghe della gelosia, le sfumature dell’eros, l’onnipotenza della passione, la superstizione dell’attesa, il rimorso dell’addio), il tempo, la decadenza e la morte (tre concetti indissolubilmente legati da un rapporto quasi metonimico di contiguità), il profumo sublime e stimolante della tristezza, lo sgomento dinanzi all’abisso del Nulla che inghiotte anche il peccato, l’ansia per una vita diversa che si indovina da una “breccia del tempo” (si ricorderanno le “malchiuse porte” montaliane), il precario e provvisorio rifugio offerto dalla poesia, dalla città (specialmente con la pioggia), dalla luna».[2]
Oppure nella sostituzione del mito della Genesi, dove la scena diventa non solo una riformulazione ma un processo metamorfico, come se ci fosse una diretta emanazione dalla primigenia di Adamo ed Eva o apparissero le tracce della Chimera e di Prometeo, dell’anima fonda di Narciso, di Endimione e delle Nereidi, delle Meduse e delle Gorgoni. E poi ancora fino a Zeus, Laio, Giocasta e Teseo:
«In principio era il principio: / con qualche titubanza uscì dal niente, / da una coltre di buio senza tempo / macchiata in rosso, come per esempio / i paesaggi di Edipo. / E poi la Sfinge, le ali ricoperte / di diamanti – ancor prima che all’aperto / le acque zampillassero veementi – / preparava solerte / tutto il rimanente».
Vaghenàs si impossessa della disillusione e della fenomenologia affettiva, che vivono la quotidianità, il passo inadatto verso l’argilla delle cose, la sparuta vertigine del tempo, l’illibata figura lunare, il sublime e la tristezza, la sete mischiata.
Arrivando fino alla sequela del grande Kostas Kariotakis, il poeta dell’ultimità cosmica o a Stèfanos Martzokis, avvolto dalla violenza violetta del buio, impastandosi nei rimandi agrodolci di Auden:
«Ora quaggiù c’è calma. Niente vento. / I diavoli al ripoo nelal cenere. C’è chi i taglia le unghie, chi rammenta / il paato. Una luna capelvenere, / dentata e tonda, ‘immerge e ‘affina / nello zolfo che ardeva e ‘è chetato. / Fiamme più bae. Dal boco bruciato / volano a tratti ciami canterini / d’angeli neri (l’Ade echeggia – è un ogno – / dell’ “In exceli DEo” in largo o andante), / mentre uno i accuccia e fa un biogno / dietro una torva pròtome di DAnte».
L’amore di Vaghenàs è un colpo di macina fragile e insicuro, geloso e doloroso, titanico e antico. Appare come un ritratto rinascimentale che omaggia Mantegna, si ammanta nella rincorsa goethiana tra le comete o nella solitudine dei racconti, diventa novembre di ginocchia sottili e assetate, «una voce che brucia / e un seno che si lascia andare» nell’esilio e respira la tenebra infinita e i giacigli inesausti, per essere andante di vertici, viaggio nei palmi:
«Scrivere il tuo nome sopra i vetri appannati, / attendere in stazioni dove hai atteso per ore, / son cose che non danno né gioia né dolore. / Suono azzurro, ancestrale, altissimo profumo, / la tua voce scintilla come la lacrima angelica. / Ma il mio amore è l’amore degli Otelli. / E quando mi rinfocola e quando mi addormenta, / rabbrividisco e vedo innanzi Iago. / Mi dico: lega i giambi con lo spago. / Le poesie sono fiori molto esili, / nutriti dalla consona tristezza. / E l’ira, se li accumula, li spezza».
Le stagioni incompiute («Indossavi un vestito color olio / ed orecchini viola d’ametista. / Era come e già ti avessi vista: / sotto un rametto pieno di boccioli / o in un abisso d’alghe fondo e triste»), le odi barbare dove i vecchi amori entrano come scaglie sradicate di sogno e di ricordo, l’oscurità e la morte, la salvezza e l’ironia musaica, la profanità di una donna distesa, fatta di terra, consegnano il suono delle sue ombre, rimestando una polvere lieve, quasi accennata, nel vento.
[1] Vaghenàs N., Ballate oscure, a cura di Filippomaria Pontani, Crocetti, Milano 2021.
[2] Pontani F., Introduzione, in Vaghenàs N., cit., pp.10-11.
Vaghenàs N., Ballate oscure, a cura di Filippomaria Pontani, Crocetti, Milano 2021, pp.144. Euro 14.
Vaghenàs N., Ballate oscure, a cura di Filippomaria Pontani, Crocetti, Milano 2021.