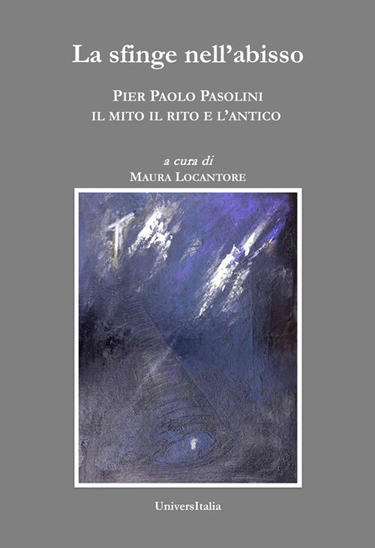La pubblicazione del saggio La sfinge nell’abisso, per Universitalia, a cura di Maura Locantore, richiede una fedeltà, potremmo dire, di esegesi e «disperata vitalità» che impone, però, cura per la parola che scava, con il corpo-a-corpo delle sue pagine, del suo cinema, della sua critica, e in definitiva, della sua arte.
Il merito di questo lavoro che recupera i materiali del convegno internazionale La Sfinge nell’abisso. Pier Paolo Pasolini a quarant’anni dalla morte. Sondaggi critici e nuove prospettive dell’opera, svoltosi dal 14 al 16 ottobre 2015, ideato dal prof. Angelo Fàvaro presso la prestigiosa Università “Aristotele” di Salonicco, con interventi di grandi studiosi e interpreti della figura e dell’opera pasoliniana, permette di guardare, con acume e acribia, grazie al merito di Maura Locantore che ne ha riunito i fili, alla sua carica predittiva e rivelatrice, la furente lucidità, la scomposizione generativa della parola, consentono al lettore di fare i conti con la figura Pasolini, che si impone, persino negli abbozzi, come forza e sperpero, abbandono e incendio, straccio e apocalisse, innervati
«da una speciale competenza-conoscenza del mito e dalla strumentazione etno-antropologica del leggendario, tanto della classicità quanto delle origini medievali e romanze; forte di una visione storica di impegno latamente gramsciano, ma che, in particolare, si avvale di una infaticabile e creativamente floridissima esplo-razione mitopoietica. Così il poeta fonda e si diffonde ossessivamente in una costante eroicizzazione-eroticizzazione dell’esistenza e della realtà[1]».
La miscellanea di saggi ha la forza, dunque, di distendere la magmatica matassa pasoliniana attraverso la vita e l’opera, il mito e il rito che cercano, dapprima, l’ancestralità valoriale e la leva di ogni “passione e ideologia”, rinunciando a ogni tentativo di epistemologia agiografica, ma intento, come ha notato Fortini, al tentativo del poeta di essere «nella vita e nella scrittura, ossesso dalla categoria sociologica e morale del piccolo-borghese, e travolto dagli sforzi eroicomici di uscirne».
L’antico, il tragico, l’immersione nel mito accolgono la luce prospettica di una insolubilità problematica che innerva il presente, per guardare tanto «la perdita dell’innocenza tanto nel proprio tessuto biografico, quanto nel corpo violentato dalla società; soltanto l’estetica primitiva, antica, barbarica, medievale, il reperimento del lontano e remoto figurale e figurativo possono ancora concedere un documento salvifico ed edenico[2]».
La sua civiltà magmatica, che guardava all’Italia di Jacopone e Gioacchino da Fiore e poi, come afferma Carlo Ossola «il dialetto friulano e Dante, i tragici greci e gli Evangeli, il sottoproletariato e la Nuova Guinea - ma non più e soltanto latina: Pasolini sa partire da Alba pratalia, alba pratalia delle nostre origini e arrivare alla lugubre Nuova Preistoria che viviamo, alla profezia degli ultimi: «La Negritudine, dico, che sarà ragione».
In certo modo – come lucidamente hanno osservato Calvino e Barthes per l’utopia di Fourier – il profetismo pasoliniano si sbilancia oltre la rasserenata compiutezza delle ideologie: supera ogni finalismo della storia prevedendo la fine della storia, e intanto della propria. Nessun altro poeta come Pasolini ha messo in scena, costantemente provandola e riprovandola in parole come sarà nei fatti, la propria morte».
Dalle connessioni con la poesia contemporanea greca (Ritsos ma anche Kavafis), dalla mitopoiesi dell’innocenza alla felix culpa, studiata da Angelo Fávaro, all’orrore del potere di Pilade, studiato da Angela Felice, che recupera la tragedia più politica di Eschilo, le Eumenidi, manifestando, nella saggezza di Atena, la germinazione futura della democrazia periclea e analizzando le derive della degradazione politica, passando, con Roberto Chiesi, attraverso le maschere fantasmagoriche e i conflitti violenti, nella gettatezza solitaria dell’Edipo Re (1967), nell’equazione gridata di sogno e mito di Medea (1969), nella demistificata (e brechtiana) dimensione onirica e nelle strutture dinamiche del Calderón, qui studiato da Loreta De Stasio, in cui lo specchio deformante del teatro, diventando, nell’autore friuliano, “teatro di Parola”, ossia una rappresentazione che, partendo dalla ritualità politica greca, poteva proporsi come una sorta di frontale rito culturale:
«Il mito non è dunque in Pasolini il recupero di un’unità che la cultura, o le culture, tendono per loro parte a diversificare, ma una figura di pensiero in cui si addensa ed enfatizza la tragedia della condizione umana. L’intensità di cui esso è caricato esprime il pieno e deflagrante terrore di una scoperta esiziale, perché legata al senso primo della vita del mondo. E ancora la storia comincia là dove finisce. Nondimeno in Pasolini il mito non si contrappone alla ragione fabulante e utopica, bensì a quel pensiero razionale e tecnico che, privo di luce, è soltanto cieco operare, freddo calcolo borghese».[3]
Il rapporto materno, allora, sarà la forza di un amore per ciò che genera e restituisce, oggetto profondo e mitico di un microcosmo infinito e archetipico che diventa mito e amore: «Dirò semplicemente che ho provato un grande amore per mia madre. La sua «presenza» fisica, il suo modo di essere, di parlare, la sua discrezione e la sua dolcezza soggiogarono tutta la mia infanzia. Sono rimasto convinto per molto tempo che tutta la mia vita emozionale ed erotica era stata determinata esclusivamente da questa passione eccessiva, che ritenevo addirittura una forma mostruosa dell’amore. Ora ho appena scoperto, molto recentemente, che anche le mie relazioni di amore con mio padre hanno avuto la loro importanza, tutt’altro che irrilevante. Non si tratta quindi solo di rivalità e di odio».
Le Poesie a Casarsa, notate già prematuramente da Contini nel saggio Al limite della poesia dialettale, rivelando come il dialetto di ca da l’aga, della riva destra del Tagliamento, diventi koinè, acquisisca valore fonico ed emblematico: «Giovinetto, piove il Cielo / sui focolari del tuo paese, sul tuo viso di rosa e miele, nuvoloso nasce il mese /….Giovinetto, ride il Cielo / sui balconi del tuo paese ,/ sul tuo viso di sangue e fiele, / rasserenato muore il mese». La sfida era la vivacità orale della Rosada, contro ogni sottomissione del dialetto, fornendo i primi segni «Insieme con le esperienze e le scoperte socioculturali che di lí a poco egli farà», di
«un trauma anzitutto privato, il martirio del fratello, è quindi all’origine della vocazione civile che Pasolini, dagli anni Cinquanta in poi, costantemente attribuirà a ciascuna delle sue opere, tanto piú rivendicandone l’afflato pedagogico quanto piú crederà la propria parola di poeta, giacché parola per l’appunto letteraria, progressivamente delegittimata da una comunità sempre meno propensa ad assegnare un qualche ruolo etico- pubblico all’intera tradizione umanistica. Atteggiamento, questo dello scrittore, che ogni volta parrà anche scaturire dal bisogno, anzitutto psicologico, di rimuovere il senso di colpa, di vergogna e, addirittura, di minorità intellettuale avvertito – proprio in quanto poeta, e quindi cultore comodamente imbelle di un facile miraggio arcadico di astratta giustizia e sterile bellezza – innanzi ai resti del partigiano Ermes».[4]
In più, «Nella trasfigurazione pasoliniana le sequenze dei mitemi più noti si trasformano in paradigma emblematico dell’inganno e dello sfruttamento, del sacrificio sull’altare del funzionalismo pragmatico e conformistico, nell’inferno della società dei consumi, che vorrebbe salvare soltanto la ritualità dell’acquisto e della produzione, eliminando financo la storia e con la storia il corpo[5]».
Essere intellettuale “disorganico” o del dissenso, significa pronunciare l’appartenenza, dapprima, a un partito il PCI (dal quale poi sarà espulso) e la coscienza di un’eguaglianza essenziale dell’umano, rigettando gli assembramenti dei valori comuni, e dei ceti dominanti, manifestando nella sua scrittura epico-realistica il senso dell’essere, la sua ricerca dell’io lirico assetato.
Il Friuli è il fiabesco teatro della sua genesi arcaica e l’immedesimazione con il Cristo crocifisso (come le antinomiche litanie degli anni ’40), e la sua stessa prosa si sposa con l’istinto di descrivere, come afferma Walter Siti, «o meglio esprimere lo sgomento d’una descrizione eternamente delusa» e per lui, «la realtà brilla, infinitamente desiderabile, disperatamente inafferrabile, in un presente assoluto – e le parole non sono che una trappola per catturarla, o per dichiararle amore».
Ecco La meglio gioventù in cui disegna il mitizzato universo contadino, l’inadeguata separatezza, la crisi di identità e il suo processo di maturazione che rappresentano l’archeologia di una stagione in divenire, e poi Roma e le fitte borgate, abitate da un sottoproletariato, microcosmo ai margini di legge e civiltà borghese, altare e sacrificio di una iniziazione linguistica e sociale che diventerà il fulcro della scena del mondo.
Attualizzare il mondo, decifrare il presente, sognare e intuire la pienezza della sua genesi, riscriversi sempre e attuare il perfetto poliedro della sua arte. Da Ragazzi di vita, passando per Una vita violenta a Le Ceneri di Gramsci, dove si afferma non solo la propria coscienza libera e il suo sacrificio, Pasolini attraversa le insistenze simboliche e le reiterazioni descrittive di una «complessione massiccia e ossessiva» che, pur abitando il Neorealismo, ne trasgredisce il mito e la transitività, in un dialetto ricalcato e autoriale.
Il processo di degradazione dei figli delle borgate non è solo espressione antifascista di emarginazione, ma impegno di una libertà, non di un popolo, ma di un sottoproletariato che è prima cifra di ciò che il Paese potrà subire. Ogni mutazione antropologica è dolorosa e obliante.
È il rintracciare l’equazione superstite della bellezza (Appennino) che può essere generativa anche nel presente, nella luce di una società affrancabile da stilemi borghesi e dalla ferocia della non-storia: «Solo restando impura, cioè ambendo alla compiutezza senza tuttavia raggiungerla, un’opera è del resto capace, per Pasolini, di assolvere un’autentica funzione pedagogica. Nel suo diniego dell’esattezza si potrà infatti riconoscere il rigetto di una concezione classicistica dell’arte – intesa appunto quale galleria di opere da giudicarsi capolavori solo quando formalmente ineccepibili – ritenuta in sé borghese dal poeta proprio perché aridamente razionalistica[6]» e manifestare «la sacralizzazione della vita, il disprezzo del conformismo sociale, la fede in un “pensiero magico”, il pauperismo. E di farlo concependo la sua intrinseca oscillazione tra un principio di ordine formale, ossessivamente istituito, e un bisogno di anarchia espressiva in egual misura assecondato, come il senso ultimo della propria proposta teorica. Alla stregua, cioè, dell’abiura di quella riduzione dell’eccedenza popolare alla norme borghesi implicita in ogni rappresentazione degli ultimi ispirata a un piatto, o prospettivistico, realismo socialista[7]».
Ne L’usignolo della Chiesa Cattolica, l’eresia dell’innocenza si scontra con la spietatezza di una Chiesa irreligiosa, spietata e peccatrice, come scrive Gian Carlo Ferretti. La nostra è la storia morsa di un puro amore, di un puro intuire in solitudine, dallo spleen come segno di contraddizione. La religione del suo tempo è la «dizione totale della realtà», dove il corpo del verso duplica l’instabilità del mondo, la catena di eros e tanatosi, la voce come sfasatura inclinata del vuoto che si riversa poi nel sogno. L’incombenza magnetica ed enigmatica di Cristo, in particolare del Christus patiens si staglia nella trepida irrisolutezza della sua anima.
Uno spasmo, un grido (come quello di Teorema), una fertile voluttà ierofanica. Uno specchio irraggiungibile, un desiderio folle di essere amato. Egli dunque mise in campo nella sua opera questo segno di contraddizione, che non è già politico o dialettico. Lo scontro con il potere di stampo tecno-consumistico riguarda il radicale cambiamento del mondo, il rapporto con la natura. Il mondo sta cambiando e Pasolini si scaglia in modo duro e violento (lo farà anche con i figli di papà del ’68): «Il mio problema, il problema della mia vita l’ho cominciato a capire quando, osservando il retro delle ginocchia dei miei amici, sentivo sorgere in me lo struggimento per una carnalità irraggiungibile, e tutta la mia vita sarebbe stata attraversata da questo senso di qualche cosa di carnale ma al tempo stesso irraggiungibile».
L’irraggiungibilità. La sua disperata vitalità è nella crisi del rapporto con la realtà, nel tradimento dei chierici (dirà che i nuovi chierici dell’omologazione saranno preti progressisti che useranno parole libertarie), nel tecnonichilismo e, infine, nella irredimibile tenerezza: «Questo può urlare un profeta che non ha la forza di uccidere una mosca, la cui forza è nella sua degradante diversità».
La diversità della domanda, il suo urlo senza fine, la ribellione di un abbraccio che degrada, la mancanza («Manca sempre qualcosa, c’è un vuoto in ogni mio intuire ed è volgare questo non essere completo, mai fui così volgare come in quest’ansia, in questo non avere Cristo»: «Amore con se stessi senza altro interesse che l’amore, lo stile, quello che confonde il sole, il sole vero, il sole ferocemente antico, sui dorsi di elefanti e i castelli barbarici, sulle casupole del Medioriente col sole della pellicola pastoso, sgranato, grigio, biancore da macero e controtipato, controtipato con altrettanta fisicità che nell’ora in cui è alto e va nel cielo, verso interminabili tramonti di paesi miseri».
Egli che mentre lavorava a quell’umanissimo e divino Vangelo secondo Matteo (1964), scrive una lettera a don Giovanni Rossi della Pro Civitate Christiana di Assisi, città dove il regista ebbe, leggendo le pagine del Vangelo nel giorno in cui era lì anche Papa Giovanni XXIII, l’idea del film: «Sono bloccato, caro don Giovanni, in un modo che solo la Grazia potrebbe sciogliere. La mia volontà e l’altrui sono impotenti… Forse perché io sono da sempre caduto da cavallo: non sono mai stato spavaldamente in sella (come molti potenti della vita o molti miseri peccatori): sono caduto da sempre, e un mio piede è rimasto impigliato nella staffa, così che la mia corsa non è una cavalcata, ma un essere trascinato via, con il capo che sbatte sulla polvere e sulle pietre. Non posso né risalire sul cavallo degli Ebrei e dei Gentili, né cascare per sempre sulla terra di Dio».
[1] Fávaro A., Introduzione – P. P. Pasolini, l’abisso e la Sfinge: dalla mitopoiesi dell’innocenza alla felix culpa, in A.a. V.v., La sfinge dell’abisso. Pier Paolo Pasolini: il mito, il rito e l’antico, a cura di Maura Locantore, Universitalia, Roma 2020, pp.8-9.
[2] Id., cit., p. 9.
[3] Locantore M., La novella dei paesi cristiani. Un autografo pasoliano, cit., p. 163.
[4] Tricomi A., Pasolini, Salerno Editrice, Roma 2020, p.35.
[5] Fávaro A., cit., p.10.
[6] Tricomi A., cit., p.94.
[7] Id., cit, p.94 e ss.
A.a.V.v., La sfinge nell’abisso. Pier Paolo Pasolini: il mito, il rito e l’antico, a cura di Maura Locantore, Universitalia, Roma 2020, pp. 305, Euro 18.